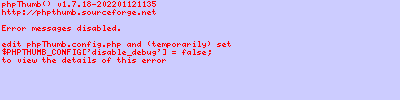Un giorno, un'impresa
26 Maggio 201326 maggio. Sarebbe interessante assistere oggi al 47° compleanno di Zola Budd, la gazzella senza scarpe che un fotografo inglese fermò in un meraviglioso fotogramma: un allenamento in mezzo a struzzi che la guardavano risentiti per averli allontanati dal loro razzolare. Zola è nata a Bloemfontein, in quella che fu la capitale della Nuova Repubblica boera o Stato Libero di Orange. In una parola, Sudafrica, escluso dal resto del mondo per la brutalità dell’apartheid che produsse martiri e orrori e su cui solo una Grande Anima (Nelson Mandela) è riuscito a calare un sipario di riconciliazione senza un bagno di sangue.
Quando Zola, che a quel tempo pareva un efebo che avrebbe fatto fremere l’imperatore Adriano, decise che l’angustia dei confini dentro cui era costretta non poteva esser sufficiente al suo talento e al suo meraviglioso ritmo, non riuscì a capire a fondo le reazioni che questa sua volontà avrebbero prodotto. Era il tempo in cui a Trafalgar Square un banchetto stazionava fisso davanti a quel grande edificio di pietra chiara, l’ambasciata del Sudafrica. Questa protesta seguì il suo apparire con la maglia della Gran Bretagna, obbligò a costituire severi servizi d’ordine, a tener alto il livello d’attenzione per questa ragazza, poco più che adolescente, che seppe dare il meglio nella corsa campestre, sia essa venisse proposta in un formato simile alla pista (come capitò in una solatia Lisbona ’85) sia che offrisse, come l’anno dopo a Cortaillod, sul lago di Neuchatel, le difficoltà di un percorso arduo e di una giornata improba, con una pioggia sottile vicina alla neve. Quel giorno, sotto una tenda, i colleghi inglesi festeggiarono attingendo felici da una cassa di birra. Zol era diventata loro.
Quei due titoli mondiali di cross le riconsegnarono una parte della pace perduta al Coliseum: perseguitata per le sue radici, finì per diventare il bersaglio del grande catino californiano quando un’altra ex-ragazzina prodigio, Mary Decker, la Little Mary d’America che un anno prima, ai Mondiali di Helsinki, aveva domato le “comuniste” Kazankina e Zaitseva, incespicò contro la sua gamba destra lasciando l’arena tra le lacrime e l’onda dell’ira. L’oro olimpico dei 3000 fu dell’ossigenata Maricica Puica e Zola, in piena rottura, finì settima, squalificata e riqualificata- “Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace”, provò a comunicare i suoi sentimenti l’imputata, ma Mary non volle sentir ragioni neppur quando la svizzera Cornelia Burki, anch’ella di nascita sudafricana, provò a spiegarle com’era andata. “So che è colpa sua e basta”, tagliò corto una furente Mary.
E così addosso a quel corpo esile sembrarono ricadere le colpe di un paese intero, di una lunga e tormentata storia. Sola e scalza per un’espiazione globale. Troppo. la sutura per quella ferita profonda sarebbe arrivata nel ’92 a Barcellona con il giro d’onore interpretato da Derartu Tulu e Elana Meyer: l’Africa nera e l’Africa bianca potevano abbracciarsi mentre Mandela tornava libero.
Giorgio Cimbrico
| Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |